
VIDEO DI ARTE
Una raccolta di approfondimenti in storia dell'arte
IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO

Il video tratta le due tendenze artistiche che si svilupparono alla fine dell’Ottocento. L’Impressionismo si diffuse in Francia con i pittori Manet, Monet, Renoir e Degas. Essi realizzavano le loro opere all’aria aperta, appresentando le impressioni che l’osservazione diretta della realtà suscitava in loro. Il Postimpressionismo prevedeva la realizzazione di dipinti in studio e una ricerca di maggiore solidità nel colore, nei contorni e nell’immagine rappresentata. I maggiori esponenti furono Seurat, Gauguin, Van Gogh e Cézanne.
L’arte della seconda metà dell’Ottocento è segnata dal contrasto fra l’indirizzo ufficiale delle accademie e i nuovi gruppi di artisti indipendenti. Il gruppo di maggiore rilevanza è quello degli Impressionisti, nato a Parigi nel 1874, con un’esposizione indipendente nello studio del fotografo Nadar. Essi spostano l’attenzione dal soggetto della pittura al linguaggio usato per rappresentarlo. La loro principale novità sta nel dipingere en plein air, all’aria aperta. Essi si accorgono che l’occhio umano non riceve dalla realtà un’immagine dettagliata, ma un insieme di colori che poi la mente rielabora in forme distinte. Inoltre la luce, a seconda delle ore del giorno modifica continuamente il colore degli oggetti. Al fine di rappresentare la prima impressione visiva gli Impressionisti elaborano una tecnica che consiste in rapide pennellate di colore, che non fissano i dettagli, ma offrono un effetto cromatico e luminoso dell’insieme.
Manet
Uno dei primi artisti che nella seconda metà dell’Ottocento inizia a rinnovare la pittura è Édouard Manet. I lavori che egli presenta al Salon ufficiale fanno scandalo e inizialmente vengono respinti.
L’Impressionismo e il Postimpressionismo
Nelle sue opere, in cui coniuga abilmente scene di vita quotidiana ai grandi modelli rinascimentali, rinuncia al disegno, all’uso della linea e ai passaggi chiaroscurali, in favore di figure che appaiono come un insieme di zone cromatiche piatte su forti e netti contrasti di tono. Manet è molto ammirato dagli Impressionisti, dai quali è anche influenzato, ma non partecipa mai alle loro esposizioni.
Monet
Alla fine degli anni sessanta dell’Ottocento Claude Monet e Auguste Renoir mettono a punto la tecnica impressionista, frutto della pittura en plein air, che permette di rappresentare la reale percezione ottica della realtà e mostra che in natura i contorni non esistono e i colori delle cose si influenzano reciprocamente. Inoltre approfondiscono lo studio degli effetti di rifrazione e riflessione della luce sull’acqua. Spesso Monet lavora contemporaneamente su più tele con lo stesso soggetto, interrompendosi ogni volta col mutare della luce, al fine di registrare l’istantaneità di una particolare condizione atmosferica in un particolare momento della giornata e dell’anno.
Renoir
Per Auguste Renoir il colore delle ombre non è marrone o nero, ma corrisponde al colore riflesso dagli oggetti che le circondano. Renoir ama rappresentare gli aspetti più leggiadri della vita urbana contemporanea e i nudi femminili, e i suoi dipinti si distinguono per la loro luce vibrante, per il colore saturo e per il caratteristico stile impressionista, in cui la scena è delineata con liberi e veloci tocchi di colore. Tuttavia, dalla metà del 1880, dopo un viaggio in Italia in cui conosce Raffaello e i maestri rinasci-mentali, Renoir rompe con l’Impressionismo, per applicare ai ritratti e alle figure una tecnica più disciplinata e più convenzionale, come nelle Bagnanti.
Degas
Benché Edgar Degas sia uno dei fondatori del gruppo degli Impressionisti, le sue opere si discosta-no leggermente da quelle dei suoi compagni: egli non propone immagini di evanescente luminosità, le cui forme si dissolvono e si confondono con la luce. Tuttavia sfrutta la luce per conferire plasticità, rifiutando così il tradizionale uso del chiaroscuro. Inoltre Degas non ama dipingere en plain air, e il genere del paesaggio è quello che usa di meno. I suoi soggetti più frequenti sono le scene di danza, le corse dei cavalli, l’opera, i caffè-concerto e la vita quotidiana.
Il Postimpressionismo
Alla fine dell’Ottocento il panorama artistico parigino si frammenta e le mostre si sostituiscono alle esposizioni accademiche. Dopo l’ultima mostra del 1886, l’Impressionismo subisce una profonda trasformazione che sfocia in nuove correnti “postimpressioniste” che daranno poi vita alle Avanguardie del Novecento.
Seurat
Nonostante gli studi accademici, gli interessi di Georges Seurat si orientano presto verso gli esempi di Delacroix e di Millet e la visita alla quarta mostra degli Impressionisti lo stimola a interessarsi alle possibilità di una resa più fedele degli effetti di luce e colore, di cui ricerca i fondamenti nei trattati scientifici. Seurat comprende le possibilità di influenza reciproca dei differenti colori: i complementari si esaltano a vicenda, mentre i toni chiari e quelli scuri evidenziano il proprio contrasto se direttamente contrapposti. Su tali basi elabora la tecnica del puntinismo, in cui i colori, invece di essere mescola-ti sulla tavolozza, sono collocati in minuscoli punti sulla tela, producendo l’effetto di una omogenea e luminosa integrazione sulla retina dello spettatore se osservata alla giusta distanza.
GauguinPaul
Gauguin si forma con gli Impressionisti, ma si discosta progressivamente da essi. Dal 1860 soggiorna spesso in Bretagna a Pont-Aven, dove coltiva, con altri artisti, un nuovo approccio mirato al superamento della rappresentazione verosimile della realtà e all’espressione degli stati d’animo interiori. Al fine di trasmettere maggiore intensità, Gauguin utilizza forme semplificate, colori simbolici e campi cromatici piatti e nettamente delimitati da contorni. Durante i suoi soggiorni a Tahiti e nelle Isole Marchesi poi, ama rappresentare una realtà semplice e pura, genuina e spirituale, non più ritrovabile nell’ambiente parigino e occidentale.
Van Gogh
Uomo dalla fragile e inquieta sensibilità, Vincent Van Gogh si dedica inizialmente a ritrarre con in-tenso realismo e con colori cupi l’asprezza della vita contadina. Nel 1886 si trasferisce a Parigi e conosce gli Impressionisti, Seurat e Gauguin. Influenzato da essi, abbandona i colori scuri, sperimenta l’accostamento dei colori complementari e ai temi di carattere sociale sostituisce nature morte e autoritratti. In questa fase i suoi quadri presentano tratti veloci, istintivi, antinaturalistici e vorticosi. Il suo intento però non è quello di riprodurre un’impressione visiva, ma quello di dare sfogo alle proprie inquietudini e trasmettere i propri stati d’animo. Insofferente per la caotica Parigi, si sposta ad Arles, dove per un certo periodo coabita con l’amico Gauguin. In questa fase fra i soggetti più ricorrenti vi sono campi di grano e fiori, fra cui iris, lillà, rose e soprattutto girasoli.
Cézanne
I primi lavori di Paul Cézanne sono caratterizzati da forti riferimenti alla classicità. In seguito, frequentando gli Impressionisti a Parigi, abbandona i soggetti classici e si concentra sul paesaggio. In questa fase le sue opere presentano alcuni tratti distintivi dell’Impressionismo, come l’en plein air, il colore steso per tocchi e la resa della tridimensionalità per mezzo del colore; tuttavia le forme sono ben delineate, ed è già possibile notare il tentativo di Cézanne di andare oltre l’impressione visiva per indagare l’essenza della realtà. Questo intento anticipa la fase successiva, in cui Cézanne si allontana dall’Impressionismo cercando di cogliere l’effettiva consistenza delle cose. Cézanne individua le strutture essenziali nella geometria e procede attraverso scomposizioni e ricomposizioni geometriche che anticipano il Cubismo.
Trascrizione dell’audio del video
L’ImpressionismoL’arte della seconda metà dell’Ottocento è segnata dal contrasto fra l’indirizzo ufficiale delle accademie e i nuovi gruppi di artisti indipendenti. Il gruppo di maggiore rilevanza è quello degli Impressionisti, nato a Parigi nel 1874, con un’esposizione indipendente nello studio del fotografo Nadar. Essi spostano l’attenzione dal soggetto della pittura al linguaggio usato per rappresentarlo. La loro principale novità sta nel dipingere en plein air, all’aria aperta. Essi si accorgono che l’occhio umano non riceve dalla realtà un’immagine dettagliata, ma un insieme di colori che poi la mente rielabora in forme distinte. Inoltre la luce, a seconda delle ore del giorno modifica continuamente il colore degli oggetti. Al fine di rappresentare la prima impressione visiva gli Impressionisti elaborano una tecnica che consiste in rapide pennellate di colore, che non fissano i dettagli, ma offrono un effetto cromatico e luminoso dell’insieme.
Manet
Uno dei primi artisti che nella seconda metà dell’Ottocento inizia a rinnovare la pittura è Édouard Manet. I lavori che egli presenta al Salon ufficiale fanno scandalo e inizialmente vengono respinti.
L’Impressionismo e il Postimpressionismo
Nelle sue opere, in cui coniuga abilmente scene di vita quotidiana ai grandi modelli rinascimentali, rinuncia al disegno, all’uso della linea e ai passaggi chiaroscurali, in favore di figure che appaiono come un insieme di zone cromatiche piatte su forti e netti contrasti di tono. Manet è molto ammirato dagli Impressionisti, dai quali è anche influenzato, ma non partecipa mai alle loro esposizioni.
Monet
Alla fine degli anni sessanta dell’Ottocento Claude Monet e Auguste Renoir mettono a punto la tecnica impressionista, frutto della pittura en plein air, che permette di rappresentare la reale percezione ottica della realtà e mostra che in natura i contorni non esistono e i colori delle cose si influenzano reciprocamente. Inoltre approfondiscono lo studio degli effetti di rifrazione e riflessione della luce sull’acqua. Spesso Monet lavora contemporaneamente su più tele con lo stesso soggetto, interrompendosi ogni volta col mutare della luce, al fine di registrare l’istantaneità di una particolare condizione atmosferica in un particolare momento della giornata e dell’anno.
Renoir
Per Auguste Renoir il colore delle ombre non è marrone o nero, ma corrisponde al colore riflesso dagli oggetti che le circondano. Renoir ama rappresentare gli aspetti più leggiadri della vita urbana contemporanea e i nudi femminili, e i suoi dipinti si distinguono per la loro luce vibrante, per il colore saturo e per il caratteristico stile impressionista, in cui la scena è delineata con liberi e veloci tocchi di colore. Tuttavia, dalla metà del 1880, dopo un viaggio in Italia in cui conosce Raffaello e i maestri rinasci-mentali, Renoir rompe con l’Impressionismo, per applicare ai ritratti e alle figure una tecnica più disciplinata e più convenzionale, come nelle Bagnanti.
Degas
Benché Edgar Degas sia uno dei fondatori del gruppo degli Impressionisti, le sue opere si discosta-no leggermente da quelle dei suoi compagni: egli non propone immagini di evanescente luminosità, le cui forme si dissolvono e si confondono con la luce. Tuttavia sfrutta la luce per conferire plasticità, rifiutando così il tradizionale uso del chiaroscuro. Inoltre Degas non ama dipingere en plain air, e il genere del paesaggio è quello che usa di meno. I suoi soggetti più frequenti sono le scene di danza, le corse dei cavalli, l’opera, i caffè-concerto e la vita quotidiana.
Il Postimpressionismo
Alla fine dell’Ottocento il panorama artistico parigino si frammenta e le mostre si sostituiscono alle esposizioni accademiche. Dopo l’ultima mostra del 1886, l’Impressionismo subisce una profonda trasformazione che sfocia in nuove correnti “postimpressioniste” che daranno poi vita alle Avanguardie del Novecento.
Seurat
Nonostante gli studi accademici, gli interessi di Georges Seurat si orientano presto verso gli esempi di Delacroix e di Millet e la visita alla quarta mostra degli Impressionisti lo stimola a interessarsi alle possibilità di una resa più fedele degli effetti di luce e colore, di cui ricerca i fondamenti nei trattati scientifici. Seurat comprende le possibilità di influenza reciproca dei differenti colori: i complementari si esaltano a vicenda, mentre i toni chiari e quelli scuri evidenziano il proprio contrasto se direttamente contrapposti. Su tali basi elabora la tecnica del puntinismo, in cui i colori, invece di essere mescola-ti sulla tavolozza, sono collocati in minuscoli punti sulla tela, producendo l’effetto di una omogenea e luminosa integrazione sulla retina dello spettatore se osservata alla giusta distanza.
GauguinPaul
Gauguin si forma con gli Impressionisti, ma si discosta progressivamente da essi. Dal 1860 soggiorna spesso in Bretagna a Pont-Aven, dove coltiva, con altri artisti, un nuovo approccio mirato al superamento della rappresentazione verosimile della realtà e all’espressione degli stati d’animo interiori. Al fine di trasmettere maggiore intensità, Gauguin utilizza forme semplificate, colori simbolici e campi cromatici piatti e nettamente delimitati da contorni. Durante i suoi soggiorni a Tahiti e nelle Isole Marchesi poi, ama rappresentare una realtà semplice e pura, genuina e spirituale, non più ritrovabile nell’ambiente parigino e occidentale.
Van Gogh
Uomo dalla fragile e inquieta sensibilità, Vincent Van Gogh si dedica inizialmente a ritrarre con in-tenso realismo e con colori cupi l’asprezza della vita contadina. Nel 1886 si trasferisce a Parigi e conosce gli Impressionisti, Seurat e Gauguin. Influenzato da essi, abbandona i colori scuri, sperimenta l’accostamento dei colori complementari e ai temi di carattere sociale sostituisce nature morte e autoritratti. In questa fase i suoi quadri presentano tratti veloci, istintivi, antinaturalistici e vorticosi. Il suo intento però non è quello di riprodurre un’impressione visiva, ma quello di dare sfogo alle proprie inquietudini e trasmettere i propri stati d’animo. Insofferente per la caotica Parigi, si sposta ad Arles, dove per un certo periodo coabita con l’amico Gauguin. In questa fase fra i soggetti più ricorrenti vi sono campi di grano e fiori, fra cui iris, lillà, rose e soprattutto girasoli.
Cézanne
I primi lavori di Paul Cézanne sono caratterizzati da forti riferimenti alla classicità. In seguito, frequentando gli Impressionisti a Parigi, abbandona i soggetti classici e si concentra sul paesaggio. In questa fase le sue opere presentano alcuni tratti distintivi dell’Impressionismo, come l’en plein air, il colore steso per tocchi e la resa della tridimensionalità per mezzo del colore; tuttavia le forme sono ben delineate, ed è già possibile notare il tentativo di Cézanne di andare oltre l’impressione visiva per indagare l’essenza della realtà. Questo intento anticipa la fase successiva, in cui Cézanne si allontana dall’Impressionismo cercando di cogliere l’effettiva consistenza delle cose. Cézanne individua le strutture essenziali nella geometria e procede attraverso scomposizioni e ricomposizioni geometriche che anticipano il Cubismo.
ARA PACIS
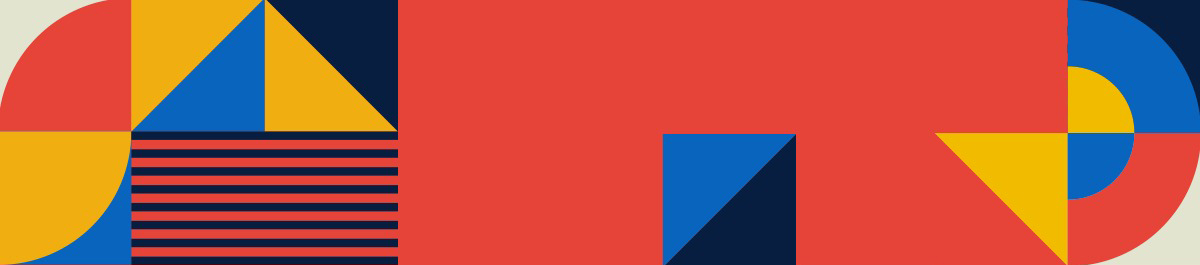
Trascrizione del testo e del video
“Quando tornai a Roma… il Senato decretò che si dovesse consacrare un’ara alla Pace Augustea”Così Ottaviano Augusto primo imperatore di Roma ricorda l’erezione di un altare nel luogo in città dove si esercitavano i soldati, il Campo Marzio, volto a celebrare il suo ritorno in patria e la fine delle guerre civili.
L’altare è circondato da un recinto marmoreo decorato con rilievi che celebrano la figura di Augusto, la sua stirpe e le sue gesta.
Il pannello situato alla sinistra dell’ingresso sul retro è forse il meglio conservato e quindi il più facilmente leggibile. Una figura femminile velata siede sulle rocce in testa a una corona di fiori e frutta e ai piedi un bue e una pecora, porta in grembo due bambini che giocano ancora una volta con della frutta.
Gli studiosi pensano si tratti di Tellus dea romana identificabile con la madre terra che produce frutti e bestiame con i quali nutre i suoi figli. Ai lati due fanciulle sorrette da un cigno e da un drago marino, dirigono su di lei i venti benevoli rispettivamente della terra e del mare a significare il clima di prosperità, pace e fertilità in cui Augusto sta per condurre il suo impero.
Lo stile scelto per celebrare questo nuovo clima politico e sociale è quello della Grecia classica di qualche secolo prima, il modello della donna seduta e drappeggiata deriva direttamente dalle sculture di Fidia per il Partenone di Atene, città simbolo di cultura e progresso, si sceglie così di tralasciare le esuberanze le scene traboccanti di pathos che nei secoli più recenti hanno dominato nel Mediterraneo in favore di un ritorno alla misura, all’esaltazione della grandezza intellettuale e morale dell’uomo e in questo caso del capo politico.
DAVID DI DONATELLO

Trascrizione del testo e del video
Niccolò di Betto Bardi detto Donatello, uno degli artisti più poliedrici e sperimentatori del Quattrocento italiano, lascia a Firenze una scultura in bronzo raffigurante il re Davide che ha suscitato molte discussioni tra gli studiosi proprio per la sua originalità.La datazione dell’Opera ad oggi più accreditata è quella che va dal 1433 al 1443, periodo in cui l’artista di ritorno dal suo secondo soggiorno romano lavora a Firenze prima di partire per Padova.
In questi anni Donatello riceve un’importantissima committenza privata, è molto probabilmente Cosimo primo dei medici a richiedere la scultura per la sua dimora, la cosiddetta casa vecchia, e a portarla con sé nel nuovissimo palazzo Medici.
Ciò che sconcerta di questa opera e che si crede possa essere una delle prime sculture a tutto tondo completamente nuda dai tempi dell’antica Roma.
Perché?
Cosa portò Donatello a un cambiamento di stile così e radicale anche rispetto a un altro Davide che lui stesso aveva scolpito circa 30 anni prima?
Forse la committenza privata e quindi la collocazione originaria dell’opera in un luogo visibile solo ad un certo tipo di pubblico appartenente alla ristretta cerchia medicea, può aver spinto Donatello a sperimentare il classicismo appreso nel suo ultimo soggiorno romano, un classicismo in cui il corpo dell’eroe e specchio di grandezza morale e quindi viene rappresentato in tutto il suo splendore, in particolare il movimento flessuoso delle membra crea una curva molto simile a quella utilizzata dallo scultore Greco Prassitele nel IV secolo avanti Cristo. Il corpo di Davide però non è scolpito come quello di un atleta nel pieno del suo vigore, ma come quello delicato indifeso di un ragazzino. Il classicismo così rivisitato da Donatello in chiave realistica apre la porta alla maniera moderna.



